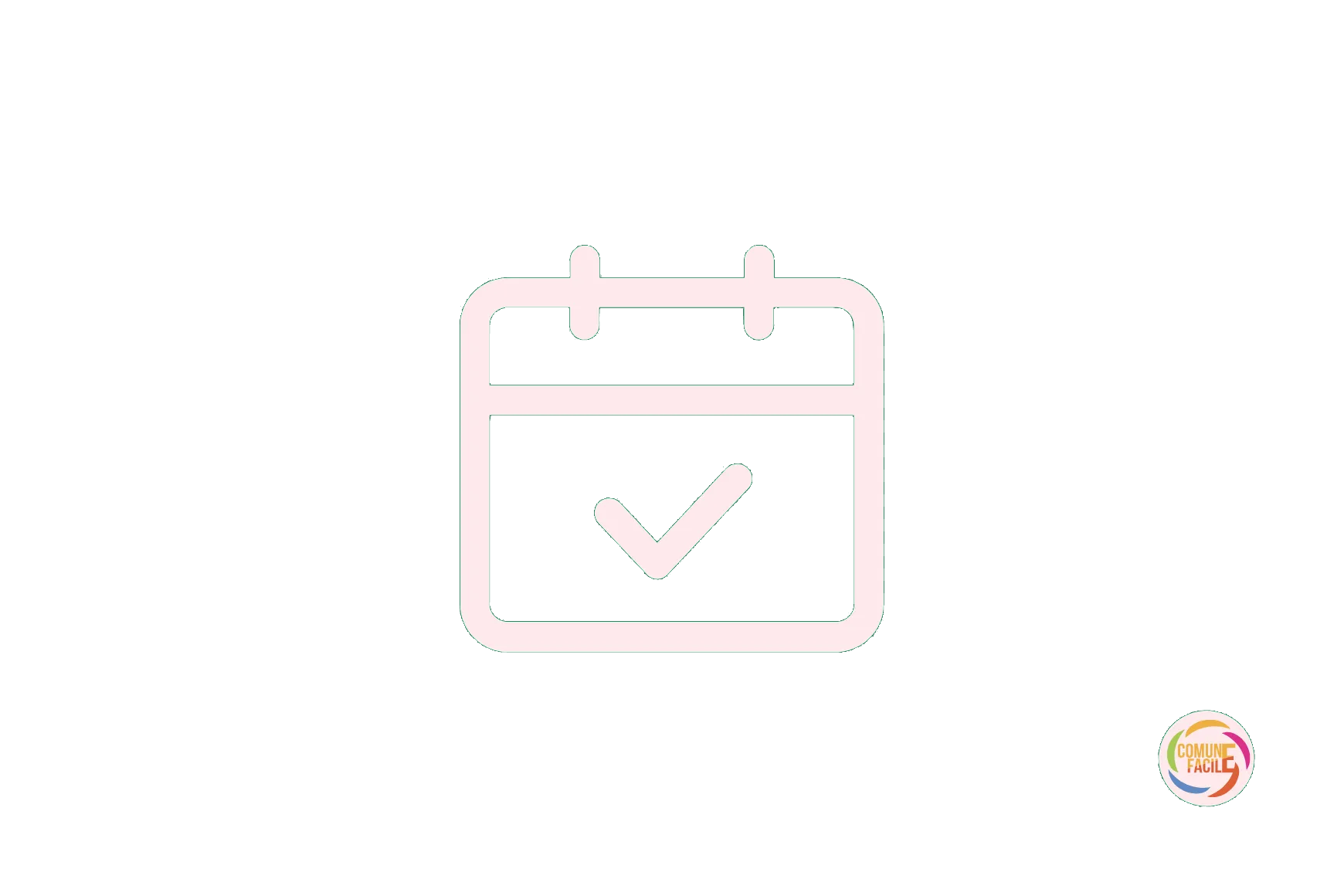Descrizione
VISIBILI/INVISIBILI
STORIE DI POPOLI E PERSONE
Nell’ambito di FILOSOFARTI 2024 - Festival di Filosofia
11 febbraio – 3 marzo 2024
L’Archivio Fotografico Italiano con il patrocinio del Comune di Castellanza (VA), nell’ambito di Filosofarti propone quattro mostre allestite nelle sale della storica Villa Pomini.
Affondare lo sguardo oltre le apparenze per dare evidenza all’invisibile – dal punto di vista ecosistemico, sociale, culturale, etico e teologico, attraverso diverse forme di analisi e di espressione artistica - per costruire a livello comunitario forme di vita, di relazioni generative e antropiche: questa la finalità del festival che quest’anno compie vent’anni di offerta culturale per il territorio provinciale e interregionale con l’obiettivo, appunto, di ‘fare comunità’.
"Villa Pomini è lieta di aprire le sue porte a FilosofArti-Festival di Filosofia - ha dichiarato Davide Tarlazzi, Assessore alla cultura e all'istruzione del Comune di Castellanza - e di ospitare per l'occasione quattro mostre fotografiche di indubbio interesse curate da Claudio Argentiero-Afi. Ancora una volta la cultura sceglie di affrontare il reale per stimolare consapevolezza e dibattito".
LE MOSTRE
ROBERTO TRAVAN
Nagorno Karabakh, la pace tradita
Cosa significa vivere in un Paese da trent'anni in guerra? Quale futuro è possibile immaginare quando la pace è costantemente appesa a un filo? Quali possono essere i sogni, le speranze, i diritti di una comunità intimamente legata alla sua terra, alla sua cultura, a una storia millenaria? Parte da queste domande il progetto a lungo termine che Roberto Travan ha iniziato nel 2016 in Nagorno Karabakh, nel Caucaso meridionale. Un viaggio attraverso gli occhi di un popolo pacifico costretto a subire un conflitto sostanzialmente ignorato dai media e dalla comunità internazionale. Una storia travagliata iniziata nel 1920 allorché Stalin inglobò questa provincia armena all’Azerbaijan. Nel 1992, in seguito all’uscita dell’Azerbajian dall’URSS, il Nagorno Karabakh proclamò legittimamente con un referendum l'indipendenza e iniziò la Prima Guerra che si concluse due anni più tardi con un fragile accordo di cessate il fuoco. Da allora, nonostante i negoziati di pace coordinati dall’OSCE, momenti di stasi si sono alternati a scontri improvvisi e sanguinosi costati quasi cinquantamila morti, più di un milione di sfollati e immense distruzioni. Nell’autunno del 2020 scoppia la Guerra dei 44 giorni: l’Azerbaijan, fiancheggiato dalla Turchia, invade e occupa larga parte dell'autoproclamata Repubblica dell’Artsakh. Nel 2022 gli azeri chiudono il corridoio di Lachin, l’unica via di accesso all’exclave armena, impedendo per oltre nove mesi qualsiasi rifornimento di cibo e generi di prima necessità. L’Azerbaijan interrompe anche le forniture di gas, acqua potabile, elettricità tenendo letteralmente in ostaggio per oltre nove mesi più di 120.000 civili. A causa del blocco la popolazione è ridotta allo stremo, negli ospedali si muore perché i medicinali scarseggiano e a nulla servono gli appelli della Comunità internazionale e le condanne dell’Onu e della Corte internazionale dell’Aja per interrompere l'assedio. L'epilogo, tragico, il 26 settembre 2023: dopo l’ennesima sanguinosa offensiva, l’Azerbaijan occupa ciò che resta del Karabakh costringendo oltre 100.000 persone a fuggire in Armenia. Da quel momento gli azeri hanno iniziato a cancellare sistematicamente qualsiasi traccia della millenaria storia armena del Karabakh, profanando chiese, cimiteri, monumenti storici nel tentativo, vano, di riscriverne la storia. La storia, l'ennesima, di una pace tradita.
Roberto Travan, giornalista professionista, fotografo indipendente, dal 2011 documenta conflitti e crisi umanitarie. Ha seguito la missione ISAF in Afghanistan, le tensioni tra serbi e albanesi in Kosovo, gli scontri interreligiosi nella Repubblica Centrafricana. Ha realizzato reportages in Israele e in Tunisia. Dal 2015 ha seguito ininterrottamente la guerra nel Donbas culminata il 24 febbraio 2022 con l'assedio di Kyiv, la capitale ucraina. Nel 2016 dopo aver documentato la Guerra dei 4 giorni in Nagorno Karabakh è stato dichiarato dall’Azerbaijan persona non grata. Successivamente, nel 2020, ha seguito la Guerra dei 44 giorni, scontro che ha anticipato la definitiva occupazione azera del Karabakh avvenuta nel 2023. Autore di mostre in Italia e all’estero, i suoi servizi sono stati in prevalenza pubblicati da La Stampa, quotidiano in cui lavora dal 1989.
REZA KATHIR E GIOVANNI MEREGHETTI
Iran, oltre il velo
Nel mondo sono quasi cento milioni le donne che indossano il velo. Con l’eleganza e la dolcezza che contraddistingue il gentil sesso - dal Maghreb al Medio Oriente, ma anche più a est - queste figure prive di un’identità apparente, si muovono nella vita di tutti i giorni in una società che per tradizione e religione le vuole così: nascoste agli occhi dello sconosciuto. Nonostante l’uso del velo islamico venga spesso additato a regole e al rispetto religioso, in realtà il Corano non ne impone l’obbligo per le donne musulmane. Ai tempi del Profeta Maometto, portare il velo per una donna era solo una distinzione di classe. Infatti, solo le sue donne lo indossavano, le signore del popolo giravano a volto scoperto. Quindi, è una libera scelta delle donne se portare il velo o mostrarsi al mondo. Tuttavia non è sempre così, i condizionamenti e le imposizioni di familiari o di gruppi islamisti, cambiano da luogo a luogo, da regime a regime. Dalla ormai tolleranza delle grandi città del Nordafrica occidentale, alle regole più ferree ed estremiste imposte dagli ayatollah durante il periodo di Khomeyni in Iran, o al fondamentalismo estremo dei Talebani dell’Afghanistan, la donna musulmana vive situazioni variegate, ma quasi sempre prive di una scelta personale. Molte donne, anche se è ormai consolidato il fatto che il velo non riveste un significato religioso, continuano a coprirsi la testa. È diventata un’abitudine acquisita nel tempo, fa parte del quotidiano, il velo è diventato parte di loro, radicato nel profondo dell’esistenza. Molte donne non uscirebbero mai di casa senza indossarlo, si sentirebbero a disagio, in qualche modo spaesate e irriconoscibili a sé stesse. Niqab, chador, hijab, burqa, sono questi i “veli” più conosciuti per coprire le parti femminili del corpo che per gli uomini rappresentano le più svariate forme di seduzione. I più integralisti percepiscono, anche in una piccola parte di pelle scoperta, un pericolo per l’integrità della tradizione. È una forma di oppressione nei confronti della donna, basata sul controllo della proprietà dell’individuo. L’onore del maschio ha bisogno di garanzie, se questa moralità viene a mancare, la donna ne deve rispondere personalmente, in alcuni paesi pagando addirittura col caro prezzo della vita. L’hijab è tra i foulard più comuni utilizzati dalle donne musulmane per coprirsi. È la copertura minima imposta dalla legge sacra della shari’a per nascondere i capelli, il collo, le orecchie e parte della fronte. Tra i fondamenti del diritto islamico, alla donna è anche imposto di celare le forme del corpo indossando abiti lunghi di fattura non aderente. Il niqab, indossato dalle donne saudite e yemenite, è un copricapo indiscutibilmente casto e rigoroso. Composto da più veli avvolti tra loro, una volta indossato lascia intravedere solo gli occhi. In questo caso la donna diventa irriconoscibile agli occhi di chiunque, assume le sembianze di un fantasma senza identità. Le donne iraniane, a seguito della rivoluzione islamica del 1979, hanno ancora oggi l’obbligo di indossare il chador. Questo indumento, simile a un’ampia mantella, ricopre il capo e le spalle lasciando scoperto solo il viso. Nonostante le regole imposte dall’Ayatollah Khomeyni imponevano il colore nero per tutti i chador, negli ultimi tempi, soprattutto tra le giovani donne, i colori dei tessuti hanno assunto toni più vivaci. In Afghanistan, durante la guerra civile venne instaurato il regime islamico teocratico dei Talebani. Il divieto alle donne di non mostrare nessuna parte del loro corpo indossando il burqa, durò per quasi cinque anni. Il burqa afghano,solitamente di colore blu o nero, copre sia la testa che il corpo. Nella parte superiore, all’altezza degli occhi, è posta una retina che permette alla donna di vedere, senza mai però essere scrutata dagli occhi indiscreti di sconosciuti. La mitologia del velo, rappresentata dal giurista e teologo siriano Ibn Taymiyya, vissuto tra il XIII e il XIV secolo, relega la donna nell’anonimato dell’oggetto femminile ad uso e consumo del maschio. Taymiyya arriva anche a proibire alle donne di guardarsi a vicenda in caso di nudità. Queste sue teorie nascono dal fatto che la bellezza femminile può creare invidie e gelosie, non solo tra gli eventuali corteggiatori, ma anche tra le donne stesse. Nei secoli, il termine velo ha assunto svariati significati. Contrariamente a quanto si pensa, il velo non è solo una tradizione del mondo arabo. Sono infatti molte le testimonianze che conducono ad un uso anche nella civiltà cristiana bizantina. Nella tradizione popolare italiana, fino a qualche decennio fa, il velo ha sempre assunto una valenza simbolica di grande importanza. Il velo bianco nuziale e quello nero del lutto, sono solo alcuni esempi che riportano all’atto riverenziale nei confronti del sacro.
Se gli occhi, come sostengono in molti, sono lo specchio dell’anima, attraverso la sottile fessura del niqab ci viene offerta un’opportunità. Quella di imparare a leggerli.
Giovanni Mereghetti inizia la sua attività di fotografo nel 1980 come free-lance. Successivamente collabora con le più importanti agenzie italiane ed estere specializzandosi in reportage geografico e fotografia sociale. Nel corso della sua carriera ha documentato l’immigrazione degli anni ’80 a Milano, il ritiro delle truppe vietnamite dalla Cambogia, la via della seta da Pechino a Karachi, l’embargo iracheno, gli aborigeni nell’anno del bicentenario australiano nonché le popolazioni Nuba del Sudan. Negli ultimi anni si è dedicato a ricerche fotografiche di carattere sociale nelle carceri italiane e allo studio dei flussi migratori provenienti dall’Africa Occidentale. È autore dei libri “Bambini e bambini” (Mesero), “Piccoli Campioni” (Pubblinova), “Ciao Handicap!” (Click), “Omo River e dintorni” (Periplo Edizioni), “Bambini Neri” (Les Cultures – Sahara el Kebira), “Friendship Highway …verso il Tibet” (Bertelli Editori), “Destinazione Mortirolo” (Bertelli Editori), “Nuba” (Bertelli Editori), “Da Capo Nord a Tombouctou… passando per il mondo” (Immagimondo- Bertelli Editori) e “Veli” (Les Cultures Edizioni). Grazie all’esperienza maturata nel settore dello styling per conto di un’importante azienda italiana, nel 2010 fonda Spazio Foto Mereghetti, laboratorio di ricerca e comunicazione visiva, operante nel settore dell’immagine di design e nella creazione di concept aziendali. I suoi lavori sono stati esposti in mostre personali e collettive presentate in Italia e all’estero. Sue opere fotografiche fanno parte della collezione dell’Archivio Fotografico Italiano. Vive e lavora in provincia di Milano.
Reza Khatir è nato nel luglio del 1951 a Teheran. Nel 1968 si trasferisce in Inghilterra per proseguire gli studi, nel 1976 interrompe gli studi di scienze dell'alimentazione al Politecnico per dedicarsi interamente alla fotografia. Nel 1977, dopo un soggiorno a Parigi, si trasferisce a Locarno per poi frequentare una scuola di fotografia a Milano. Ha iniziato la sua carriera professionale come fotoreporter lavorando a vari incarichi in Medio Oriente per importanti agenzie e riviste. Dopo numerosi viaggi, che gli hanno offerto una preziosa esperienza, nel 1981 fonda la propria agenzia fotografica (Skylite) a Locarno. Nel 1986 lancia con un amico la rivista FLAIM, edita in Svizzera e successivamente partecipa come editore alla pubblicazione della rivista “CHIAROSCURO” di Milano. Nel 1988 fonda una piccola casa editrice attraverso la quale pubblica diversi libri d'arte e di fotografia. Tra il 1981 e il 1992 ha lavorato esclusivamente con pellicole Polaroid in tutti i formati, e molto spesso con la gigante Polaroid 20x24"(50x60cm). Dal 1979 ad oggi ha condotto ricerche personali spesso legate alla memoria, ha esposto in gallerie e musei di tutto il mondo , tra cui il National Museum for Photography Bradford. Musée D'Art et Histoire, Friburgo. Canon Photo Gallery, Amsterdam. UNO (Unesco), New York. Scotish Counsil, Edimburgo. Museo De Arte Contemporanea, Caracas. Galerie Nikon, Zurigo . Galleria Il Diaframma, Milano. Musée des Beaux Arts, La Chaux-de-Fonds. Kunstmuseum, Olten. Museo Cantonale d'Arte, Lugano. Museo Biasca, Biasca. Munich Stadtmuseum, Monaco di Baviera. Museo de Arte Contemporanea, Madrid. Musée de l'Elysée, Losanna, Victoria and Albert Museum, Londra. Museum of Modern Art, Città del Messico. Hamburger Kunsthalle, Amburgo e Palazzo delle Esposizioni, Roma. Ha pubblicato i suoi lavori in numerose riviste, libri e cataloghi e ha vinto numerosi premi fotografici internazionali. Nel 1985 è stato selezionato da una giuria di curatori e storici dell'arte come uno dei 12 "The New Swiss Photographers" per la rivista DU e nel 1986 è stato invitato a partecipare alla mostra al Photokina di Colonia, che ha raccolto alcuni dei più influenti fotografi a colori in tutto il mondo per celebrare il 50° anniversario della fotografia a colori. Nel 1991 ha partecipato alla mostra ufficiale intitolata "Voir La Suisse Autrement" per celebrare il 700° anniversario della Confederazione Helvetica. È stato anche selezionato per 3 dei 5 volumi Polaroid "Selections" Polaroid International Collection. Nel 2001 il lavoro di Reza Khatir è stato pubblicato nel volume Photography 7th Edition, edito da Pearson Education, Prentice Hall. Fino al 2017, oltre all'attività di fotografo freelance, è stato Photo-Editor per il settimanale svizzero "Ticinosette" e fino a 2019 docente di fotografia e comunicazione visiva alla SUPSI (Università di Scienze Applicate e Arti della Svizzera Italiana).
UGO PANELLA
Ucraina, dalla parte dei bambini
Ogni nuovo conflitto oscura la memoria del precedente. Due anni fa l’avvento dei talebani in Afghanistan attivò i media di tutto il mondo e per settimane Kabul è stata il centro di ogni notizia.
Poi, nel febbraio del 2022 la Russia attaccò l’Ucraina e l’attenzione mediatica dimenticò i talebani per immergersi in questo nuovo, inaspettato conflitto. Ora è toccato a Gaza cancellare la memoria dell’Ucraina ma non di quella guerra. La velocità con la quale si consumano avvenimenti, catastrofi e conflitti segue la corsa bulimica che questo nostro tempo tecnologico impone alla nostra capacità di comprensione degli avvenimenti. L’Ucraina non è indenne da tale processo schizofrenico. Pochi dati per capire : 22 mesi di guerra 70.000 militari ucraini uccisi e 150.000 feriti 250 militari e civili russi uccisi 5.000.000 di espatriati ucraini dall’inizio del conflitto. Questo fa capire, al di là dei freddi numeri, la portata di un avvenimento che avrà una strada ancora lunga prima di una qualunque risoluzione diplomatica. In queste settimane i russi stanno mettendo a punto “l’offensiva d’inverno”, in Crimea sono già pronti 800 missili onyx capaci di una velocità pari a quella del suono e programmati per distruggere le centrali elettriche. La popolazione ucraina avrà un rigido inverno senza luce né riscaldamento e questo provocherà altri morti nelle fasce più deboli della popolazione. Il lessico militare li chiama “effetti collaterali” mentre quello umano ha nomi, cognomi e vite interrotte. In questo scenario una parte degli abitanti, quelli rimasti, si ritaglia un quotidiano difficile che cerca di dimenticare i pericoli sempre presenti, i droni che volano sulle città sganciando bombe e il suono delle sirene che costringono a rifugiarsi nel primo luogo sicuro. Le città vivono di riti interrotti e di quotidiane file ordinate e silenziose davanti ai pochi negozi aperti. Sono tornato a Kiev varie volte guardando il procedere di questo conflitto. Il mio compito è testimoniare la vita dei bambini ricoverati all’ospedale nazionale del cancro e vedere da vicino un’ulteriore tragedia. Quella dei bambini con patologie tumorali e quella dei genitor vittime di un destino che non lascia tregua. Questo ospedale, fondato nel 1968, è stata la sola struttura della capitale in grado di accogliere molti bambini e bambine vittime delle radiazioni dovute allo scoppio della centrale di Chernobyl il 26 aprile 1986. Ricordo la prima volta che sono entrato in quella struttura nel febbraio del 2008. Pareti scrostate, soffitti chiazzati di umidità, la ruggine sui letti dei ricoverati e la difficoltà di avere protocolli di cura adeguati alle malattie oncologiche. Nel tempo molto è migliorato ma questa guerra ha riportato alla luce quelle difficoltà e soprattutto la scarsità di medicinali fondamentali per le cure. Mancano gli antidolorifici, la sala operatoria non ha sempre a disposizione la tecnologia necessaria per affrontare operazioni complicate e i medici devono combattere con la paura delle bombe e dei missili che cadono molto vicino e terrorizzano i bambini ricoverati. Le finestre vengono protette con delle strisce di nastro isolante per evitare che lo spostamento d’aria delle granate trasformino in proiettili le schegge di vetro. I genitori di questi bambini cercano, pur nel dolore, di dare conforto e tenerezza al proprio bambino che vive smarrito ogni ora della giornata. Alcuni di loro hanno perso la casa per i bombardamenti nelle zone più accese del conflitto. Sopportano pesi psicologici e pratici difficilmente immaginabili da chi è lontano, per sua fortuna, dalle conseguenze di una guerra. S’intrecciano storie che hanno protagonisti i bambini.
IANA, ha quattro anni e pochi mesi fa era in viaggio con i suoi genitori. Il treno era diretto a L’Viv. All’improvviso un mig russo si abbassa verso i convogli e sgancia una bomba. Il treno prende fuoco e così il vagone dove viaggiava. I genitori sono morti bruciati e Iana si è salvata rimanendo ustionata dalla testa a metà corpo. La guardo mentre le infermiere la fasciano dopo le medicazioni, sento il suo pianto disperato che non ha interruzione e penso al suo futuro negato.
NATALIA , 5 anni, ha subito gli effetti indiretti del conflitto. Non è stata colpita da proiettili o da mortai ma, nascosta nel bunker durante un attacco missilistico, al buio e al freddo i genitori avevano acceso una lampada a petrolio per fare luce e scaldarsi. Lei l’ha urtata tirandosela addosso. Il fuoco le ha distrutto la schiena e il petto. Anche questo fa la guerra. Storie che si intrecciano stanza dopo stanza, nei corridoi con i lettini accanto alle finestre protette dai sacchi di sabbia che dovrebbero proteggere.
TANIA, 6 anni, proviene dalle zone di contatto del Donbass. Sei mesi fa un’esplosione vicino alla sua abitazione. Una scheggia della bomba l’ha raggiunta alla schiena e le ha leso dei nervi, Non camminava più. Trasportata a Kiev è stata operata e dopo mesi di rieducazione motoria riesce a restare in ginocchio per qualche minuto. La mamma ha la speranza di vederla camminare ma non sa come né quando.
Piccole e grandi storie umane che il conflitto amplifica e rende eroiche. La guerra non distrugge solo edifici, ponti e città, la guerra distrugge il futuro e l’identità di ogni persona coinvolta. Questo conflitto, come tanti altri, non chiede la classifica tra i buoni e i cattivi. Risponde a logiche dettate dai potenti della terra senza interessarsi di chi paga sulla propria pelle la distruzione della propria vita. Appunto…gli effetti collaterali. Ora l’Ucraina subirà l’offensiva d’inverno. Quando le temperature scenderanno sotto lo zero e la neve cadrà copiosa, sono gia pronti in Crimea 800 missili in attesa di salutare una nuova ondata di massacri. C’è ancora chi crede possibile portare la pace in tante zone del mondo promuovendo la guerra!
Ugo Panella inizia la carriera di fotogiornalista documentando i conflitti in Centro America alla fine degli anni ’70. In particolare, la guerra civile in Nicaragua e, più tardi, quella in Salvador. In questo Paese ha realizzato un reportage in collaborazione con UNCHR (Alto Commissariato per i Rifugiati) sugli atti di pace e la deposizione delle armi da parte del gruppo guerrigliero “Farabundo Martì “alla fine degli anni ’80. Atti che ponevano fine ad un decennio di massacri. In Bangladesh ha documentato la fatica di migliaia di uomini che, nel porto di Chittagong, smantellano navi cargo a due dollari al giorno, in condizioni di lavoro difficili.
Sempre in Bangladesh, in collaborazione con l’inviata esteri di “Repubblica” Renata Pisu, ha realizzato un lungo reportage sulla condizione di migliaia di ragazze sfigurate dall’acido solforico perché rifiutano le “avances” di uomini violenti. Questo lavoro è stato pubblicato dalle maggiori testate internazionali ed ha costretto il governo di quella nazione a cambiare le leggi, introducendo la pena di morte per chi si rende responsabile di simili delitti. Il suo lavoro lo ha portato in Albania, centro e sud America, India, Sri Lanka, Filippine, Oman, Cipro, Palestina, Somalia, Etiopia, Sud Africa, Iraq, Afghanistan, Ucraina, Sierra Leone.
In Italia ha realizzato un lungo lavoro nell’Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello in Calabria. Un istituto psichiatrico dove centinaia di persone vivevano in condizioni di abbandono. Questo reportage è diventato un progetto tradotto nel libro fotografico “In direzione ostinata e contraria”. In collaborazione con Soleterre Onlus ha realizzato un lungo reportage sui tumori infantili derivanti da disastri ambientali, lavorando soprattutto in Ucraina, Marocco, Salvador, Guatemala e Costa d’Avorio. Da molti anni documenta in Afghanistan i progetti di microcredito della Fondazione Pangea Onlus mentre il suo ultimo lavoro è dedicato ai flussi migratori in Africa, in modo particolare Mali, Nigeria, Gambia e Senegal. Nel 2009 ha vinto il premio Eugenio Montale per il fotogiornalismo.
CAMILLA ALBERTINI
Donne e motori. Gioie e basta
Concept Elisabetta Cozzi
"Di stereotipi sulle donne ce ne sono tanti e quelli che le collegano al mondo delle automobili sono particolarmente denigratori e tra i più difficili da eliminare. La mostra, giunta alla II edizione, vuole essere un contributo per combattere le immagini che distorcono la realtà e per superare la cultura discriminatoria. Protagoniste sono 20 donne di alta professionalità ritratte a bordo delle auto del Museo Fratelli Cozzi.
La fotografa Camilla Albertini le ritrae alla guida, colpendo con la forza di immagini eleganti e rispettose i luoghi comuni antiquati e retrogradi. Per sensibilizzare tutti sull’urgenza del contrasto alla violenza e di una vera parità, che nasce anche dalle battaglie culturali.
Camilla Albertini è fotografa e videomaker. Nata a Milano, si è laureata nel 2017 in fotografia presso l’Istituto Europeo di Design e conta come freelance già una lunga esperienza di lavoro in diversi ambiti: dallo still life in studio al reportage, dall’automotive al corporate, dal ritratto al food. È appassionata di disegno e di arti visive in genere. Ama viaggiare e cogliere nelle sue immagini l’essenza dei luoghi con immagini mai scontate e di ricercata emozione. Con l’occhio e il cuore sempre attenti alle tematiche femminili, ha realizzato nel 2019 un reportage sulle donne islandesi e nel 2022 e 2023 una mostra fotografica, in collaborazione con il Museo Fratelli Cozzi, di ritratti di donne e automobili, per scardinare gli stereotipi legati a “donne e motori”. Diverse le sue immagini e testi pubblicati nelle pagine del Corriere della sera di Milano e da riviste quali Quattroruote, Ruoteclassiche, Donna Moderna, Gardenia, il Bagno. Nel 2021, per Silvana Editoriale, ha pubblicato, con il collega Paolo Carlini, il libro fotografico “Italia Cost to Coast”.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Luogo: Villa Pomini – Via Don Luigi Testori, 14 – Castellanza (VA)
Periodo espositivo: 11 febbraio – 3 marzo 2024
Inaugurazione e visita guidata alle mostre: domenica 11/02/24 ore 17
Orari visita: sabato 15-18,30 / domenica 10-12 – 15-18,30
Ingresso Libero
Organizzazione: Archivio Fotografico Italiano
Curatore: Claudio Argentiero /Afi
Contatti e informazioni: e-mail afi.fotoarchivio@gmail.com
sms 3475902640 – Whatsapp 333 3718539
www.filosofarti.it